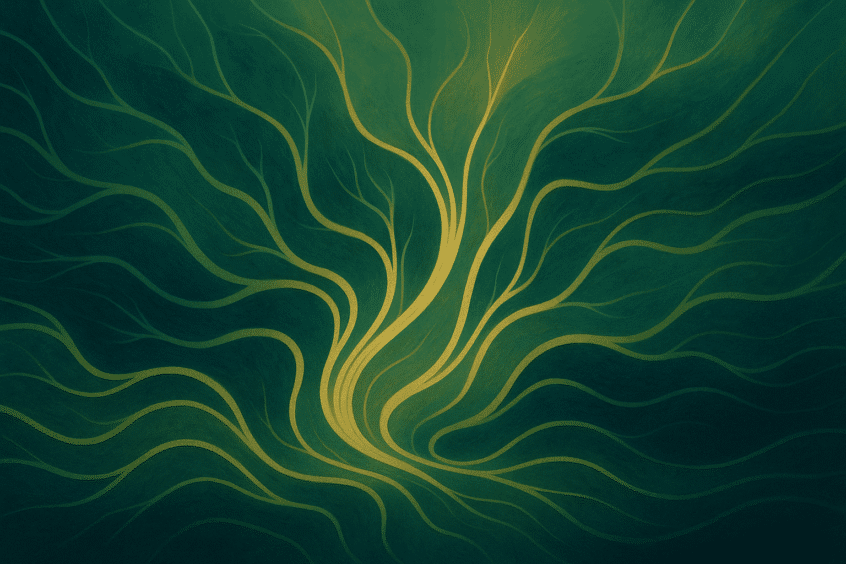Abstract
Nel discorso corrente sul Reiki circola un lessico psicologico che promette “rilascio dei blocchi emozionali” e “guarigione delle ferite interiori”. Questo articolo problematizza tale psicologizzazione, mettendo in dialogo il monito gramsciano contro il riduzionismo dell’io con l’antropologia dell’embodiment e una prospettiva decoloniale. Laddove il Reiki viene ricodificato come psicoterapia dolce, si appiattisce la sua natura corporea e relazionale: mani che sostano, posture, respiro e silenzio costruiscono un’esperienza intersoggettiva che sfugge alla sola interiorità. Da un’altra angolazione, la traduzione psicologistica alimenta una “spiritualità bianca” che universalizza il malessere e rimuove genealogie, paesaggi e pratiche giapponesi. L’obiettivo è riaprire lo spazio della cura come etica del corpo-in-relazione, restituendo al Reiki densità tecnica e culturale, e invitando a una narrazione responsabile capace di tenere insieme esperienza vissuta, storie e mondi.
Perché parlare oggi di psicologismo nel Reiki
Nelle pagine web delle scuole di Reiki e nei materiali divulgativi che circolano in Italia, ricorrono formule che collocano la pratica dentro un immaginario psicologico: si parla di “blocchi emozionali”, di “traumi non risolti”, di “ferite interiori da risanare”. L’immagine che ne risulta è quella di una disciplina terapeutica intesa come psicoterapia dolce, un laboratorio dell’io dove il malessere viene diagnosticato in termini esclusivamente interiori ed emotivi.
Questa torsione linguistica ha una genealogia precisa. Come mostrano gli studi sulle religioni del New Age (Hanegraaff, 1996), la spiritualità occidentale contemporanea tende a riformulare pratiche diverse — dal buddhismo allo yoga fino al Reiki — come strumenti per lavorare sulla propria interiorità psichica, attraverso una traduzione in categorie terapeutiche familiari al pubblico euroamericano. Il successo di questo linguaggio si spiega con la sua promessa di immediatezza: parlare di emozioni, di guarigione interiore, di benessere psicologico consente di avvicinare pratiche complesse con un registro apparentemente neutro e universale.
Da un’altra angolazione, tuttavia, tale psicologizzazione produce un effetto riduttivo: sposta l’attenzione dall’esperienza incarnata, situata e relazionale del Reiki a una funzione di auto-aiuto individuale, inscritta nei circuiti di consumo spirituale e di mercato della psicologia pop (Illouz, 2008; Rose, 1999). In altre parole, laddove il Reiki diventa “terapia delle emozioni”, rischia di perdere il suo statuto di pratica relazionale e simbolica per essere ricodificato come variante accessibile di counseling.
Lo psicologismo come riduzionismo: il monito di Gramsci
Antonio Gramsci, nei Quaderni del carcere, usa la parola “psicologismo” per indicare quella tendenza a spiegare fenomeni complessi — sociali, storici, culturali — attraverso categorie puramente individuali e psichiche (Gramsci, 1975). Si tratta di un errore epistemologico, perché sposta la sofferenza e il conflitto da uno spazio collettivo e relazionale a una dimensione privata, decontestualizzata.
Applicato al Reiki, questo riduzionismo produce una forma di spiritualità depoliticizzata: le difficoltà dell’esistenza vengono interpretate come “blocchi interiori” da sciogliere, oppure come “traumi” da rielaborare, occultando la trama di condizioni materiali e simboliche in cui tali vissuti emergono. Da un’altra angolazione, il linguaggio psicologista non è mai neutro: definendo il malessere come squilibrio interiore, relega il lavoro del Reiki a una palestra emotiva dell’io, oscurando i rapporti di potere, le disuguaglianze sociali, le strutture di senso che attraversano i corpi.
Gramsci ci aiuta a comprendere come questa operazione sia egemonica: tradurre i problemi in termini psicologici significa addomesticarli, renderli compatibili con un linguaggio di auto-aiuto che appare universale e naturale. Ma universale non è: appartiene a una modernità occidentale che tende a leggere ogni forma di sofferenza come esperienza privata, inscritta nella sfera dell’individuo (Williams, 1977).
Il rischio, per il Reiki, è diventare un dispositivo che legittima questa stessa visione, venendo assimilato a una terapia dolce dell’interiorità e perdendo il suo radicamento in pratiche corporee, relazionali e rituali.
Il corpo come orizzonte relazionale: oltre la mente individuale
L’antropologia dell’embodiment ha aperto una prospettiva decisiva: l’esperienza non è riducibile a stati mentali o a dinamiche interiori, ma si struttura attraverso il corpo come luogo di senso, relazione e memoria. Thomas Csordas (1994) ha parlato del corpo come “sito di emergenza del significato”, sottolineando che ogni vissuto si radica nella carne e nei gesti prima di tradursi in pensiero. Lock e Scheper-Hughes (1987) hanno proposto l’idea di “mindful body”, mostrando come il corpo sia contemporaneamente biologico, sociale e simbolico.
Se guardiamo il Reiki attraverso questa lente, le esperienze narrate durante i trattamenti — sensazioni di calore, immagini spontanee, vibrazioni che attraversano — non possono essere interpretate come mere “proiezioni psichiche”. Esse sono piuttosto fenomeni incarnati, che prendono forma in un contesto intercorporeo: le mani che sostano, il respiro che si sincronizza, la postura che crea uno spazio di risonanza tra praticante e ricevente.
Da un’altra angolazione, la fenomenologia di Merleau-Ponty (1945/2003) ci offre un linguaggio capace di restituire questa dimensione: il corpo è “carne del mondo”, medium attraverso il quale ci apriamo all’altro e al paesaggio. Nel Reiki, questo si traduce in una pratica che non si limita a “curare emozioni represse”, ma che produce un’esperienza situata, dove il gesto del tocco diventa un atto di presenza condivisa.
Problematicizzare lo psicologismo, qui, significa allora rifiutare la riduzione del trattamento a introspezione individuale: l’esperienza Reiki non si esaurisce nella mente del singolo, ma accade nello spazio relazionale tra corpi, in quel terreno comune che l’antropologia descrive come intersoggettività incarnata.
Psicologismo e spiritualità bianca
Il linguaggio psicologista non agisce in astratto: esso si intreccia con dinamiche storiche e culturali che hanno contribuito a costruire una spiritualità occidentale universalizzante, spesso definita “spiritualità bianca”. Parlare di Reiki in termini di “guarigione emozionale universale” significa inscriverlo in un discorso che rimuove le sue radici giapponesi, decontestualizzandolo e rendendolo disponibile come prodotto di auto-aiuto neutro, privo di appartenenze storiche e culturali.
Come ha mostrato Walter Mignolo (2011), la modernità occidentale si sostiene attraverso una logica di appropriazione epistemica che traduce pratiche altre in categorie proprie, neutralizzando differenze e complessità. È proprio questo che accade quando il Reiki viene spiegato come “psicoterapia energetica”: il riferimento alla psiche diventa la cornice totalizzante, funzionale a un mercato spirituale che offre soluzioni immediate al malessere individuale.
Antropologhe come Fedele (2013) hanno notato che la psicologizzazione non è mai innocente: essa partecipa alla costruzione di un soggetto spirituale tipicamente occidentale, in cerca di autenticità attraverso la rielaborazione emotiva, ma slegato da contesti comunitari o rituali. Da un’altra prospettiva, questa operazione rafforza ciò che possiamo chiamare “spiritualità bianca”: un orizzonte che presenta pratiche non-occidentali come strumenti universali di guarigione interiore, occultando così le storie di razzializzazione e i rapporti di potere implicati nella loro traduzione.
In questo senso, lo psicologismo nel Reiki non è solo un riduzionismo epistemologico, ma anche un gesto politico: produce un’appropriazione che rende la pratica funzionale alle esigenze dell’individuo occidentale contemporaneo, annullando differenze e genealogie. È proprio questa neutralizzazione che rende il Reiki appetibile come “psicoterapia dolce”, ma al prezzo di un esproprio culturale.
Conseguenze pratiche: il Reiki come psicoterapia dolce
Quando il linguaggio psicologista diventa il filtro principale, il Reiki scivola verso una funzione di “psicoterapia dolce”, ovvero una pratica che promette guarigione emotiva rapida, a basso costo e senza la fatica di un percorso strutturato. In Italia, molti siti di scuole Reiki parlano esplicitamente di “cura dei traumi emozionali”, “guarigione delle ferite dell’infanzia”, “scioglimento dei blocchi psichici”. Alcuni offrono i trattamenti come complementari alla psicoterapia, altri li presentano addirittura come alternativa più accessibile.
Questa torsione ha almeno tre conseguenze. La prima riguarda la perdita della dimensione tecnica del Reiki: la pratica non viene più narrata come un insieme di gesti, di posture, di tempi e di silenzi, ma come catalizzatore di processi interiori. Si produce così una sorta di svuotamento dell’arte, che diventa una cornice narrativa generica in cui tutto è ridotto a “rilascio emozionale”.
La seconda conseguenza è l’assimilazione della pratica a un immaginario psicospirituale che appartiene al mercato del benessere. Come ha mostrato Eva Illouz (2008), la cultura terapeutica moderna si struttura come industria che vende emozioni e processi di guarigione interiore. Il Reiki, in questo scenario, si trasforma in un prodotto fra tanti, presentato come strumento di self-help energetico che consente di “liberarsi dai condizionamenti emotivi”.
La terza conseguenza riguarda il posizionamento del praticante: quando il Reiki diventa una sorta di counseling energetico, l’insegnante o l’operatore si configura implicitamente come “terapeuta dell’anima”, con il rischio di sovrapporre ruoli e di generare ambiguità professionali. Questo non significa che l’aspetto psicologico non sia presente nell’esperienza — lo è inevitabilmente — ma che ridurre tutto a quell’aspetto cancella la complessità relazionale e simbolica della pratica.
In altre parole, lo psicologismo produce un Reiki addomesticato, conforme alle logiche del mercato terapeutico occidentale, ma disancorato dalla sua genealogia giapponese e dalla sua natura corporea e intersoggettiva.
Verso un’etica del corpo e della relazione
Problematicizzare lo psicologismo non significa negare che l’esperienza Reiki possa avere effetti psicologici. Significa piuttosto resistere alla riduzione della pratica a una funzione di auto-aiuto interiore, recuperandone la profondità corporea, relazionale e simbolica.
Un’etica del Reiki può emergere laddove il trattamento venga inteso come esperienza incarnata e condivisa: le mani che sostano non “curano l’inconscio”, ma aprono uno spazio di risonanza tra corpi; la postura del praticante non “sblocca emozioni represse”, ma costruisce un campo di presenza; il ritmo del respiro non “rielabora traumi”, ma mette in comunicazione due vite nella loro vulnerabilità reciproca. In questa prospettiva, la pratica diventa un gesto fenomenologico: un modo di abitare la carne del mondo, nel senso indicato da Merleau-Ponty, e un atto di co-costruzione di significato, come suggerito da Csordas (2002).
Da un’altra angolazione, il discorso decoloniale ci invita a non tradurre il Reiki esclusivamente attraverso categorie psicologiche occidentali. Restituirgli dignità significa riconoscerne la genealogia giapponese, i paesaggi e le ritualità da cui proviene, evitando di dissolverlo in un linguaggio universalizzante che appiattisce le differenze. Stuart Hall (1997) ci ricorda che la rappresentazione non è mai neutra: il modo in cui raccontiamo una pratica ne plasma il senso. Parlare del Reiki come “psicoterapia energetica” significa ridefinirlo in funzione dei bisogni occidentali, oscurando ciò che di più radicale esso porta con sé: un’esperienza del corpo come relazione e del benessere come interdipendenza.
In altre parole, un’etica del corpo e della relazione non rifiuta il dialogo con la psicologia, ma lo colloca in un orizzonte più ampio: quello di una cura che è al tempo stesso tecnica, presenza, memoria culturale e apertura all’altro. Laddove lo psicologismo traduce il Reiki in introspezione individuale, questa etica lo restituisce alla sua natura intercorporea e situata.
FAQ – Psicologismo e Reiki
❓ Qual è il significato antropologico del termine embodiment?
Embodiment indica il corpo come soglia vissuta dove esperienza, cultura e identità si intrecciano.
In questa prospettiva (Csordas), il Reiki è una pratica situata: tocco, respiro e postura generano significato
nell’incontro tra corpi, non soltanto nella mente individuale.
❓ Perché Gramsci e Hall sono utili per leggere il Reiki oggi?
Gramsci aiuta a riconoscere il rischio del riduzionismo psicologico che privatizza il malessere;
Hall mostra come le rappresentazioni plasmino ciò che chiamiamo “Reiki”. Insieme, offrono una lente
per comprendere traduzioni culturali, egemonie e costruzione di senso.
❓ Cosa significa parlare di “decolonialità” a proposito del Reiki?
La decolonialità (Mignolo) invita a non appiattire il Reiki in categorie occidentali di auto‑aiuto.
Significa riconoscerne genealogia giapponese, paesaggi e ritualità, evitando appropriazioni che
cancellano differenze e storie.
❓ Qual è il legame tra antropologia medica e Reiki?
L’antropologia medica (Scheper‑Hughes & Lock) mostra che la salute è un intreccio biologico‑sociale‑simbolico.
Il Reiki opera in questo intreccio: il trattamento apre uno spazio relazionale in cui corpo, emozioni,
immaginazione e contesto culturale co‑producono benessere.
Mini-glossario
Psicologismo: tendenza a ridurre fenomeni complessi – sociali, culturali o corporei – a spiegazioni di natura esclusivamente psicologica.
Embodiment: concetto antropologico che descrive l’esperienza come incarnata nel corpo e nelle sue relazioni, non riducibile alla sola mente.
Spiritualità bianca: espressione critica che indica l’appropriazione occidentale di pratiche spirituali non-europee, depurate delle loro radici storiche e culturali e universalizzate come strumenti individuali di auto-aiuto.
Mindful body: nozione introdotta da Lock e Scheper-Hughes per descrivere il corpo come intreccio di dimensioni biologiche, sociali e simboliche.
Bibliografia
-
Csordas, T.J. (1994) Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self. Cambridge: Cambridge University Press.
-
Csordas, T.J. (2002) Body/Meaning/Healing. New York: Palgrave Macmillan.
-
Fedele, A. (2013) Looking for Mary Magdalene. Alternative Pilgrimage and Ritual Creativity at Catholic Shrines in France. New York: Oxford University Press, 2013.
-
Gramsci, A. (1975) Quaderni del carcere. Edizione critica a cura di V. Gerratana. Torino: Einaudi.
-
Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London ; Thousand Oaks, CA: Sage in association with the Open University.
-
Hanegraaff, W.J. (1996) New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden ; New York: Brill.
-
Illouz, E. (2008) Saving the Modern Soul. Therapy, Emotions, and the Culture of Self‑Help. Oakland: University of California Press.
-
Lock, M. e Scheper-Hughes, N. (1987) «The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology», Medical Anthropology Quarterly, 1(1), pp. 6–41.
-
Merleau-Ponty, M. (1945/2003) Fenomenologia della percezione. Milano: Il Saggiatore.
-
Mignolo, W.D. (2011) The Darker Side of Western Modernity. Durham: Duke University Press.
-
Rose, N. (1999) Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. 2nd ed. London: Free Association Books.
-
Williams, R. (1977) Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.