La luce è diventata uno dei simboli centrali della spiritualità contemporanea, spesso associata alla guarigione, alla purezza e all’elevazione. Ma cosa accade quando la luce si trasforma in una norma, in un criterio di valore che esclude chi attraversa il dolore, la fatica o la vulnerabilità? In questo articolo, problematizziamo la retorica della luce nelle pratiche spirituali come il Reiki, analizzandone le implicazioni attraverso il concetto di spiritual bypassing e le prospettive decoloniali. Ne emerge la proposta di un’etica della presenza e della relazione: un Reiki capace di abitare anche l’ombra, senza giudicare, senza correggere, senza imporre salvezze.
La luce come metafora centrale nella spiritualità contemporanea
Nelle pratiche terapeutico-spirituali come il Reiki, la luce non è soltanto una metafora, ma un vero e proprio codice simbolico che struttura l’esperienza, orienta i gesti e definisce implicitamente ciò che ha valore. Essere «nella luce», «portare luce», «canalizzare luce» sono espressioni ricorrenti che evocano non soltanto uno stato energetico positivo, ma anche una condizione esistenziale ritenuta desiderabile, elevata, evoluta. In altre parole, la luce diviene non solo linguaggio, ma norma: ciò che guida, giustifica, seleziona.
Questa centralità della luce si inserisce in una genealogia più ampia, che attraversa le spiritualità moderne e post-secolari, caratterizzate da ciò che Paul Heelas e Linda Woodhead (2005) hanno definito self-spirituality — un orientamento in cui la ricerca del sé interiore coincide con una tensione verso stati di coscienza superiori, spesso rappresentati come luminosi, puri, chiari. «La luce» in questo senso non è mai neutra: essa rinvia a un immaginario di ascesi, guarigione, purezza, verità. Essere «luminosi» significa essere spiritualmente avanzati, moralmente retti, energeticamente potenti. Il percorso spirituale viene così descritto come un movimento verticale, un’ascensione: si lascia l’ombra per salire verso la luce.
Da un’altra prospettiva, la luce funziona come elemento di distinzione. Chi “risplende” emana fiducia, carisma, potere spirituale. Chi è “opaco” o “bloccato” rischia di essere percepito come bisognoso di guarigione, in uno stato inferiore o intermedio. Tale dispositivo simbolico agisce spesso in modo implicito, ma produce effetti tangibili: nelle dinamiche di gruppo, nelle relazioni terapeuta/cliente, nella costruzione di ruoli e gerarchie all’interno delle comunità spirituali.
Nel Reiki, dove il gesto è silenzio e il contatto è ascolto, la luce può essere invocata come principio-guida, come canale di trasmissione, come manifestazione della presenza. Tuttavia, laddove questo simbolo assume caratteri dogmatici o normativi, esso rischia di trasformarsi in una prescrizione morale: «devi essere nella luce», «devi mantenere la vibrazione alta», «non lasciarti contaminare dalle energie basse». La luce smette di essere uno spazio simbolico aperto e diventa un dovere, un obbligo esistenziale, un’aspettativa interiorizzata.
Problematizzare il concetto di luce, in questo contesto, significa chiedersi quali visioni dell’umano e della guarigione vengano veicolate attraverso tale metafora, e quali esperienze ne restino escluse o silenziate. Chi decide cosa significa «essere nella luce»? E quali corpi, quali voci, quali emozioni vengono considerate inadeguate, non ancora “pronte”, da correggere o elevare?
Rischi di esclusione e idealizzazione: spiritual bypassing e dissimulazione del dolore
Se la luce diventa simbolo-guida e valore assoluto all’interno delle pratiche spirituali, allora tutto ciò che vi si oppone — l’ombra, la fatica, il turbamento, il lutto, la rabbia — rischia di essere relegato ai margini dell’esperienza terapeutica o, peggio, patologizzato. Il linguaggio della luce, quando elevato a norma, produce una forma di sorveglianza morale e spirituale che può generare sensi di colpa, auto-repressione e solitudine in coloro che non si sentono “allineati” con l’energia del gruppo o con l’ideale del praticante “centrato”. In altre parole, chi non si sente nella luce viene implicitamente posto fuori dalla comunità simbolica del benessere.
Il concetto di spiritual bypassing, coniato dallo psicoterapeuta John Welwood (2000), aiuta a nominare questa dinamica: si tratta dell’utilizzo delle pratiche spirituali per evitare — piuttosto che affrontare — le ferite emotive, le dissonanze psichiche, i traumi irrisolti. Le frasi come «lascia andare», «non nutrire il dolore», «tutto accade per una ragione» sono spesso impiegate per velocizzare, semplificare o contenere il dolore altrui. Ma, da un’altra angolazione, esse diventano dispositivi di dissimulazione: strategie simboliche per negare ciò che disturba l’immagine armonica della pratica spirituale.
Nel contesto del Reiki, questa forma di elusione può assumere sfumature particolarmente insidiose. Il dolore — emotivo o fisico — rischia di essere letto esclusivamente come “blocco energetico”, come mancanza di apertura alla luce, come carenza di lavoro su di sé. La sofferenza viene così inscritta in una narrativa evolutiva: è “necessaria”, è “maestra”, è “passaggio”. Ma questa narrazione, se non accompagnata da una reale presenza empatica e da una capacità di ascolto delle rotture, può produrre l’effetto opposto: far sentire il soggetto ancor più distante, ancor più manchevole, ancor più sbagliato. La spiritualità, invece di accogliere, sorveglia.
Chi non riesce a “vibrare alto”, chi attraversa un periodo di fragilità, chi si sente stanco o arrabbiato, viene così spinto verso un doppio silenziamento: interiore (auto-colpevolizzazione) e relazionale (timore di condividere il proprio stato). In questo senso, il Reiki — quando ridotto a pratica di riallineamento alla luce — rischia di perdere la propria funzione originaria: quella di incontro incarnato, di presenza non giudicante, di silenziosa compagnia nel dolore dell’altro.
Problematicizzare lo spiritual bypassing non significa delegittimare le esperienze di luce, ma restituire dignità e spazio anche a ciò che nella vita spirituale non è chiaro, non è lineare, non è luminoso. Significa, in fondo, riconoscere la complessità dell’umano.
Chi resta nell’ombra? La marginalizzazione del dolore nei gruppi spirituali
Se il linguaggio della luce diventa grammatica dominante delle pratiche spirituali, allora ciò che non si conforma a tale lessico — la crisi, la tristezza, l’ambivalenza, l’apatia, la disperazione — rischia di essere non solo taciuto, ma escluso. In molte comunità legate al Reiki e ad altre forme di spiritualità contemporanea, la sofferenza non trova sempre un luogo dove essere ascoltata senza essere interpretata, trasformata, trascesa. Essere nella luce diventa una sorta di performance collettiva, una forma di aderenza simbolica al modello implicito del “praticante consapevole”: positivo, grato, energeticamente “pulito”.
Da un’altra angolazione, questa pressione a mostrarsi sempre “in armonia” può generare esperienze di solitudine interiore e di vergogna. Chi vive un momento di disagio può sentirsi fuori posto, temere di essere un peso per gli altri, o percepire che le proprie emozioni disturbano la coerenza energetica del gruppo. Il disagio non viene nominato, o viene subito ricondotto a una causa spirituale, a un nodo karmico, a una mancanza personale di lavoro su di sé. La spiritualità si fa norma, la norma si fa gerarchia, e la gerarchia produce marginalizzazione.
Nelle dinamiche gruppali del Reiki — specialmente in contesti formativi o cerimoniali — si riproducono spesso micro-gerarchie simboliche legate alla capacità di incarnare e trasmettere la luce. Chi “emana luce” viene ascoltato, seguito, proposto come esempio. Chi si mostra vulnerabile può essere accolto solo a condizione che si ponga già sulla via del superamento, della guarigione, della trasmutazione. In altri termini, il dolore può essere ammesso, ma solo se è temporaneo, pedagogico, trasformabile. Il dolore persistente, l’incomprensione, la malinconia silenziosa — tutto ciò che non si risolve — rischia di diventare un’alterità scomoda, da rimuovere o rieducare.
Questa dinamica non è esclusiva del Reiki, ma riguarda molte forme di spiritualità emozionale contemporanea, come osservato da autori come Linda Woodhead e Adam Possamai. Tuttavia, nel Reiki, dove il corpo è al centro della pratica e l’energia viene intesa come linguaggio sottile, il rischio di collegare direttamente lo “stato dell’anima” con l’efficacia terapeutica del trattamento può risultare particolarmente problematico. Chi non guarisce, chi non si illumina, chi non cambia vibrazione, appare come un’anomalia da spiegare.
Ma ogni corpo ha i suoi tempi. Ogni soggettività attraversa il buio in modo unico. E ogni percorso autentico di cura — spirituale o meno — dovrebbe saper stare anche lì, nel luogo in cui non si sa, non si riesce, non si può. In questo senso, la luce può diventare spazio di accoglienza solo se si lascia contaminare dall’ombra. Solo se smette di essere un confine identitario e diventa un gesto: quello di restare accanto, anche senza sapere cosa dire.
Pratichi Reiki o stai pensando di iniziare?
Questa guida gratuita è per chi vuole (ri)scoprire le basi della pratica con uno sguardo rigoroso, lontano da slogan e semplificazioni.
Un modo per capire come insegniamo Reiki nel nostro centro — e perché è diverso da ciò che forse conosci già.
L’etica della presenza: abitare la complessità dell’umano
In un contesto in cui la spiritualità si struttura spesso come aspirazione alla luce, alla guarigione e alla trasformazione, il rischio è che il dolore venga riconosciuto solo in funzione della sua “utilità evolutiva”, come passaggio da superare, come lezione da interiorizzare. La sofferenza, così addomesticata, perde la sua forza di interpellazione, la sua irriducibilità, la sua richiesta di ascolto. Si trasforma in segnale da interpretare, in sintomo da ricodificare, in ostacolo da trasmutare. Ma che ne è del dolore che resiste, che non insegna nulla, che non si lascia redimere?
È in questo spazio che può emergere un’altra possibilità etica, fondata non sul superamento, ma sulla presenza. Presenza come qualità dell’essere-insieme, come apertura radicale alla densità dell’altro, come disposizione a restare anche laddove non c’è luce, laddove il senso manca, laddove il corpo è attraversato da stanchezza, confusione, vulnerabilità. Presenza che non guarisce, non spiega, non consola, ma accompagna. Una postura che si colloca fuori dalla logica della prestazione spirituale, e che richiede piuttosto una rinuncia: rinunciare a voler cambiare l’altro, per poterlo incontrare.
Nel Reiki, questa etica si concretizza nel gesto dell’imposizione delle mani — un gesto che, nella sua essenzialità, può farsi ascolto silenzioso, contatto non invasivo, spazio sospeso. Quando liberata dalle aspettative di risultato, la pratica Reiki può diventare un’esperienza di cura relazionale in cui l’altro non è un corpo da “riequilibrare”, ma una presenza con cui co-abitare un frammento di tempo. Da un’altra angolazione, potremmo dire che il Reiki si apre a un’etica della vulnerabilità: non si tratta di portare luce all’altro, ma di permettere a entrambi di stare insieme in una zona d’ombra.
Questo modo di intendere la pratica implica anche un ripensamento del ruolo dell’operatore Reiki: non più colui che “canalizza” o “trasmette energia”, ma colui che si fa testimone incarnato della complessità altrui, senza bisogno di risolverla. È una posizione scomoda, fragile, non eroica. Eppure è forse quella che più si avvicina a una cura autentica, non paternalista, non spiritualmente correttiva. Una cura che non cerca di guidare l’altro verso la luce, ma che gli permette di abitare il proprio buio senza solitudine.
In questo senso, la luce cessa di essere un traguardo da raggiungere e diventa un gesto relazionale, una qualità della presenza, un modo di esserci. Non qualcosa che si possiede, ma qualcosa che si condivide, anche — e soprattutto — quando non si ha nulla da offrire se non il proprio esserci.
Decolonizzare la luce: genealogie spirituali e poteri simbolici
Laddove la luce viene evocata come principio universale di guarigione, verità o evoluzione, raramente ci si interroga sulle sue genealogie culturali, sulle implicazioni storiche e sulle strutture di potere che l’hanno resa l’archetipo simbolico per eccellenza della spiritualità contemporanea. Eppure la luce, come segno, non è mai neutra: porta con sé secoli di costruzione ideologica, affondi religiosi, immaginari coloniali. Parlare di luce senza interrogarne le implicazioni equivale a perpetuarne inconsapevolmente gli effetti normativi.
La modernità occidentale — dalle sue radici cristiane fino all’Illuminismo — ha insistentemente posto la luce come metafora del progresso, della razionalità, della salvezza. La luce “illumina i popoli”, “porta la civiltà”, “disperde le tenebre dell’ignoranza”. Non è un caso che l’espansione coloniale europea sia stata giustificata anche attraverso una missione di illuminazione spirituale: convertire, educare, redimere. In questo senso, la luce si è costituita come dispositivo epistemico e politico, utile a legittimare la superiorità dell’Europa bianca, cristiana, civilizzata.
Decolonizzare la luce, allora, significa decostruire questa retorica salvifica che si ripresenta — trasfigurata ma ancora attiva — anche nelle pratiche spirituali contemporanee. Significa riconoscere che quando parliamo di “energia di luce”, “essere di luce”, “canali di luce”, stiamo utilizzando un vocabolario che si è formato entro un orizzonte storicamente segnato da asimmetrie culturali, razziali e spirituali. Come ha mostrato Walter Mignolo (2011), ogni concetto apparentemente universale va interrogato dal punto di vista delle sue condizioni di produzione geopolitiche e culturali.
Inoltre, come hanno evidenziato autrici come Sara Ahmed e Gloria Anzaldúa, l’associazione tra luce, purezza e bene produce una forma di violenza simbolica: impone una linea divisoria tra chi è “luminoso” e chi è “oscuro”, tra chi è “chiaro” (nell’anima, nel pensiero, nel corpo) e chi non lo è. Da un’altra prospettiva, possiamo leggere in questa dinamica un’eco del white universalism: quell’universalismo fittizio che, nel suo proporsi come neutro e aperto, finisce per cancellare le differenze, subordinandole a un ideale invisibilmente bianco, spiritualmente “superiore”.
Nel Reiki occidentale, tali tracce si ritrovano — spesso inconsapevolmente — nei discorsi sulla “vibrazione alta”, sulla “trasparenza energetica”, sulla “connessione alla fonte di luce pura”. Ma chi definisce cosa è puro? Chi stabilisce cosa vibra alto? Quali esperienze corporee, emotive, culturali vengono incluse nel campo della luce e quali ne restano escluse, considerate troppo dense, troppo materiali, troppo legate alla “terrestrità”?
Decolonizzare la luce, in ultima analisi, significa restituirle una densità storica, culturale e relazionale: accettare che essa non è un punto di partenza né un punto d’arrivo, ma una costruzione simbolica situata, che può essere problematizzata, attraversata, risignificata. Significa rinunciare alla luce come ideale egemonico, per farne piuttosto un possibile linguaggio relazionale tra molti altri. Una possibilità, non una verità. Un incontro, non un’imposizione.
Reiki come spazio critico: riconoscere, non rimuovere
Se la luce — come abbiamo visto — può diventare un dispositivo normativo, spirituale e culturale, il Reiki ha però la potenzialità di disattivare questa deriva, a patto che venga praticato e insegnato come spazio critico, e non come tecnica salvifica. Critico non nel senso accademico del termine, ma nel senso etico, incarnato, relazionale: un luogo dove ci si possa fermare, ascoltare, stare con ciò che c’è, anche quando non è armonico, anche quando non è luminoso.
Tornare alla semplicità del gesto — le mani che si posano, la presenza che si offre, il respiro che accompagna — significa riconoscere che il Reiki, nella sua essenza, non è un linguaggio prescrittivo, ma una pratica di contatto che si costruisce di momento in momento, nell’incontro tra due soggettività situate, vulnerabili, temporanee. Laddove questa pratica si apre alla possibilità di accogliere anche il non-detto, anche la fatica, anche il disincanto, essa può trasformarsi in uno spazio di vera cura.
Questo implica un ribaltamento: non più portare luce come forma di “intervento correttivo”, ma stare accanto come forma di riconoscimento. Non imporre un ordine energetico, ma co-abitare il disordine emotivo senza giudizio. Non spiritualizzare ogni cosa, ma lasciarsi toccare dalla realtà nella sua opacità. In altre parole, si tratta di passare da una spiritualità della trascendenza a una spiritualità della prossimità.
Un Reiki così inteso non chiede di essere nella luce, ma di esserci. Di rendersi disponibili a un incontro che non abbia come scopo la trasformazione dell’altro, ma l’ascolto reciproco. Questo non esclude la possibilità di cambiamento, ma ne rifiuta la forzatura. Non cancella il desiderio di stare meglio, ma ne problematizza l’ideologia. Non rinnega la luce, ma ne restituisce la fragilità.
Decolonizzare la luce, infine, non significa disfarsi della spiritualità, ma sottrarla alla sua deriva narcisistica, performativa, coloniale. Significa restituirle il suo potenziale umano: non la perfezione, ma la prossimità; non l’ascesi, ma la relazione; non il risveglio, ma la compagnia.
In questo senso, Reiki può ancora essere un luogo. Ma solo se smette di essere un altare, e si lascia diventare una soglia.
FAQ – Luce, Reiki e pratiche contemporanee
❓ Perché la “luce” è centrale e come passa da metafora a norma?
Nelle spiritualità contemporanee (self‑spirituality), la luce non descrive solo uno stato desiderabile: diventa un codice che orienta gesti, valori e appartenenze. Essere “nella luce” segnala avanzamento spirituale e rettitudine: la metafora si fa norma, stabilendo cosa è elevato e cosa è da lasciare “nell’ombra”.
❓ Cos’è lo spiritual bypassing e che rapporto ha con il linguaggio della luce?
È l’uso della spiritualità per evitare ferite e conflitti emotivi. Quando la luce è eretta a valore assoluto, frasi come “lascia andare” o “vibra alto” possono diventare dispositivi di elusione del dolore: invece di accoglierlo, lo si accelera o moralizza, generando senso di colpa in chi non “risplende”.
❓ In che modo la retorica della luce produce gerarchie ed esclusioni nei gruppi?
Se “luminoso” equivale a “evoluto”, chi è opaco o sofferente viene percepito come carente o “non pronto”. Nascono micro‑gerarchie (chi emana luce guida, chi non vibra alto tace) e pratiche di marginalizzazione del dolore persistente. Il rischio è trasformare la cura in performance e sorveglianza morale.
❓ Cosa significa “decolonizzare la luce” e quale etica della presenza propone il Reiki?
Decolonizzare la luce vuol dire storicizzare un simbolo presentato come universale, riconoscendone gli usi salvifici e gerarchici della modernità occidentale. Nel Reiki, ciò si traduce in un’etica della presenza: meno imposizioni di “vibrazioni alte”, più ascolto incarnato. Non portare luce come correzione, ma stare accanto anche nell’ombra, senza ridurre la sofferenza a “blocco” da superare.
Luce spirituale: metafora ricorrente nelle pratiche spirituali contemporanee, spesso associata a verità, guarigione, elevazione. In contesti terapeutici, può assumere un valore normativo che esclude chi attraversa esperienze di dolore o disagio.
Spiritual bypassing: termine coniato da John Welwood per descrivere l’uso della spiritualità per evitare il confronto con emozioni difficili, traumi o compiti interiori, privilegiando evasione e positività artificiale.
Ombra: nell’ambito psicospirituale, è l’insieme di emozioni, esperienze e parti di sé ignorate o rifiutate, spesso considerate “basse”, “negative” o non spirituali — elemento centrale per evitare l’esclusione emotiva.
Etica della presenza: postura relazionale che privilegia l’ascolto senza giudizio, la vicinanza umana nel dolore e nel buio, senza l’urgenza di trasformazione o illuminazione.
Decolonialità della luce: approccio critico che problematizza il simbolo della luce come eredità del pensiero occidentale/coloniale, chiedendo di situarlo storicamente e culturalmente piuttosto che assumerlo come archetipo universale.
Bibliografia
Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Anzaldúa, G. (1987). Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.
Heelas, P. and Woodhead, L. (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.
Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press.
Possamai, A. (2005). Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. Brussels: P.I.E.-Peter Lang.
Welwood, J. (2000). Toward a Psychology of Awakening: Buddhism, Psychotherapy, and the Path of Personal and Spiritual Transformation. Boston: Shambhala.
Woodhead, L. (2007). “Why So Many Women in Holistic Spirituality? A Puzzle Revisited”. In: «Social Compass», 54(2), pp. 149–165.

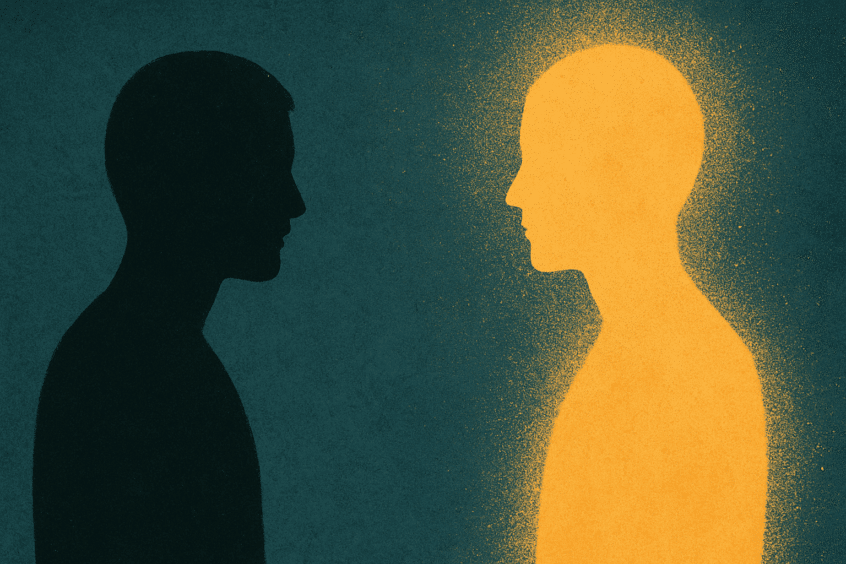
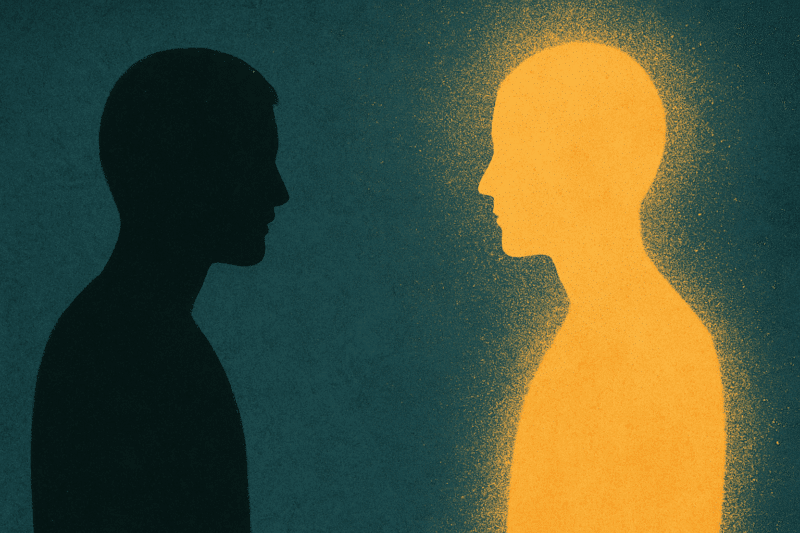
2 Comments on “Reiki e luce: spiritual bypassing, ombra e cura autentica”
È certamente una questione derimente quella che attiene alla definizione di luce, in tutte le sue sfaccettature, specialmente quando si coniuga, a forza secondo me, con il concetto di guarigione che, quando applicato ai trattamenti che operiamo, diventa di per sé già una forma egoica di giudizio sullo stato di salute, fisico, emotivo o spiriuale, della persona che stiamo trattando.
Ma “luce” rappresenta anche una raffigurazione semplice di una condizione alla quale tendere se ci si trova nelle zone d’ombra della vita. Ed è inevitabile farne, spesso incolpevolmente, una “norma” non foss’altro che destinata a dare speranza di percorrere una via nuova che conduca verso un altrove più sereno. La luce rappresenta in ognuno di noi, un senso di liberazione e perché dunque non “usarne l’accezione comune” a fin di bene. Ciò che a mio parere è più importante è l’interpretazione che di “luce” dà l’operatore nel suo ruolo di strumento a disposizione della luce stessa, nella speranza che si senta sempre grato di poter vivere di luce come strumento di relazione, comunicazione, compassione e accompagnamento nei confronti di persone e situazioni che l’universo pone sul suo cammino, per trasformare l’ombra, il vuoto, il dolore in nuove espressioni fisiche, emotive e spirituali proprie di un’esistenza luminosa nella quale la luce non sia un’eccezione, una meta da raggiungere, bensì un porto sicuro durante le tempeste della vita. prima nasce la luce poi l’ombra … ricordiamolo sempre
Grazie per l’attenzione
Grazie di cuore per il tuo commento, che sento come profondamente generativo, soprattutto nel modo in cui solleva — anche senza volerlo — una questione che mi sta molto a cuore: quella del rapporto tra luce e ombra, e di come questa relazione venga narrata, simbolizzata, interiorizzata nelle pratiche spirituali.
La frase che proponi — «prima nasce la luce, poi l’ombra» — può apparire, a un primo sguardo, come un’affermazione poetica, pacificante, persino rassicurante. Ma è proprio in quelle immagini che sembrano “ovvie” che si annidano spesso le metafisiche più radicate. Dire che la luce viene prima significa proporre un ordine cosmologico preciso, dove la luce è principio e l’ombra deriva, è effetto secondario, deviazione. È un paradigma di senso che ci orienta nel mondo, e come tale non è neutro.
Il punto non è negare il valore trasformativo dell’immagine della luce. Ma chiedersi: cosa accade quando quella luce diventa una norma? Quando diventa la misura di ciò che è “giusto”, “alto”, “guarito”? E cosa succede, allora, a ciò che non si lascia illuminare? Dove vanno a finire le crepe, le pieghe, le zone grigie dell’esperienza? Quelle che non si offrono alla chiarezza, quelle che resistono alla simbolizzazione, quelle che parlano un altro linguaggio, meno lineare, meno solare?
In molte cosmologie, luce e ombra non si susseguono, non si gerarchizzano. Si tengono. Si danno insieme. In certe tradizioni spirituali non occidentali, non è la luce a produrre l’ombra, ma è dalla soglia che emergono entrambe, come processi intrecciati. Alcune filosofie del corpo, della percezione, dell’interiorità, ci ricordano che ciò che vediamo — ciò che chiamiamo “luce” — non è mai trasparente, mai pienamente nostro. Il visibile stesso ha bisogno dell’ombra per potersi dare. Senza ombra, la luce è puro accecamento.
Merleau-Ponty parlava del “fondo d’ombra” dell’apparire. Anche la cura, forse, ha un fondo d’ombra. Non tutto ciò che accade in un trattamento Reiki è riconducibile alla chiarezza, alla coerenza, al progresso. A volte la trasformazione si manifesta attraverso forme ambigue, stanchezze, silenzi. A volte il corpo parla con gesti minimi, e quel linguaggio non vuole essere “illuminato”, ma accolto così com’è.
In questo senso, il rischio che vedo nell’affermare che “prima nasce la luce” è quello di proiettare una teleologia implicita: l’idea che l’energia, il bene, la verità, siano sempre “davanti a noi”, come traguardo da raggiungere, come condizione superiore. Questo modello, per quanto spirituale, somiglia molto a una certa forma di razionalismo occidentale, che ha costruito per secoli una storia del mondo fondata sulla luce come conquista, come civilizzazione, come dominio. Laddove c’era buio — si diceva — bisognava portare la luce. E così sono passati anche il colonialismo, la missione, la pedagogia dell’illuminazione forzata.
Ecco perché, oggi, sento che il lavoro della pratica non è “portare luce”, ma interrogare il desiderio stesso di farlo. Da dove viene? Che posizione occupiamo quando lo esprimiamo? Cosa rischiamo di non vedere mentre lo facciamo?
Per me, praticare Reiki è anche questo: sospendere la tentazione di ordinare, di spiegare, di salvare. Non perché la luce sia sbagliata, ma perché ogni luce disegna un’ombra. E perché, in alcuni momenti, è proprio nell’ombra che si apre una possibilità diversa: non di vedere meglio, ma di restare accanto.
Con gratitudine e rispetto,
Federico